Estratto da “Krínomai. Rivista italiana di storia e critica delle Arti”, n. 1 (Milano, 2025), pp. 27-62.
1 – Immagini di una memoria alterata
Dalla città di Zirma i viaggiatori tornano con ricordi ben distinti:
un negro cieco che grida nella folla, un pazzo che si sporge dal
cornicione d’un grattacielo, una ragazza che passeggia con un puma
legato al guinzaglio. In realtà molti dei ciechi che battono il bastone
sui selciati di Zirma sono negri, in ogni grattacielo c’è qualcuno che
impazzisce, tutti i pazzi passano le ore sui cornicioni, non c’è puma
che non sia allevato per un capriccio di ragazza. La città è
ridondante: si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente.
Torno da Zirma: il mio ricordo comprende dirigibili che volano in
tutti i sensi all’altezza delle finestre, vie di botteghe dove si
disegnano tatuaggi sulla pelle ai marinai, treni sotterranei stipati di
donne obese in preda all’afa. I compagni che erano con me nel
viaggio invece giurano d’aver visto solo un dirigibile librarsi tra le
guglie della città, un solo tatuatore disporre sul suo pacchetto aghi e
inchiostri e disegni traforati, una sola donna-cannone farsi vento
sulla piattaforma di un vagone. La memoria è ridondante: ripete i
segni perché la città cominci ad esistere2.
Non soltanto questo passaggio, ma tutte Le città invisibili, visionario resoconto che Marco Polo imbastisce per il Kublai Kan, è immaginato da Italo Calvino come un invito a tagliare le cime che ci legano agli ormeggi per lasciarci così andare alla deriva immaginifica della nostra e dell’altrui fantasia. Una fantasia fatta di giochi di luce e trasparenze, limpide forme dal profilo rigoroso e dalle tinte vaporose digradanti verso il colore della carta, verso la superficie del nostro spirito. Il racconto delle città invisibili diventa poesia attraverso l’incedere delle forme immaginate, così come possiamo intuire il loro profilo sulla carta e le tracce di pigmento non del tutto disciolto. Come si trattasse dell’acqua di quella pozzanghera che da secoli giace in un angolo remoto, eppure luminosissimo, della nostra mente.
L’acquerello è il farsi della poesia dal fondo di una macchia di colore brillante colto nell’atto di asciugarsi, mentre perde il suo bagliore. L’osservatore, nel passare gli occhi su quello scampolo di carta cromato, sente vibrare ancora un barbaglio di luce, l’ultimo che la carta ha trattenuto, per amore, solo per amore. Come quel lettore che, cercando d’infilarsi negli occhi le parole sognate per sé dall’autore, rimane sorpreso dal fatto che ciò che resta di tutto quel trambusto emotivo è solo una goccia d’acqua salata consumata tra le rughe del volto.
Ecco, l’acquerello si costruisce con elementi piccoli, cose umili e fragili, superfici trasparenti che narrano, nel loro stratificarsi, i più intimi moti dell’anima, proprio mentre nascono e si sviluppano come reazione ad avvenimenti e oggetti concreti. Come afferma Calvino, la memoria dev’essere ridondante, dal momento che ha bisogno di incomprensibili ripetizioni per esistere e conservare al meglio. La memoria dell’artista, allo stesso modo, ha bisogno di alterazioni, riduzioni e semplificazioni da una parte; dall’altra, necessita di ossessioni visive e zoom compulsivi che forniscono dettagliatissime, quanto inutili, descrizioni di brandelli immaginifici. L’artista isola sul foglio un segno, una traccia di colore, come il poeta lavora attorno a quelle poche parole su cui si struttura l’intera poesia.

Con l’acquerello si è però lontani dall’Impressionismo, giacché offre tutt’altro rispetto alla realistica visione d’insieme che istintivamente potrebbe rimandare a tutti quei movimenti artistici che traggono ispirazione diretta dalla realtà. L’impressione ha bisogno di osservare il paesaggio e restituire sulla tela un’imitazione di ciò che gli occhi possono vedere e come possono vederlo. Il pittore impressionista annovera sulla tela ogni possibile alterazione della forma del soggetto, subita sotto lo scacco della luce. È acclarato come gli impressionisti rivolgessero una parte sostanziale delle loro energie ad analizzare, con un approccio parascientifico, i fenomeni naturali, soprattutto quelli legati alla luce e quindi al colore. È altresì evidente quanto questa osservazione poi abbia condizionato, a vario titolo ed in diversi modi, le loro opere. Come sostiene Mario De Micheli, l’Impressionismo è l’ultimo movimento artistico basato sull’osservazione della realtà. Dopo quella stagione, a partire dall’Espressionismo3, sino ad arrivare a molte delle avanguardie storiche, gli artisti tendono a sottrarsi al confronto con la realtà e soprattutto al condizionamento imposto da questa sino ad allora. A differenza delle esperienze precedenti però, gli impressionisti tentano di ritrarre la realtà così come appare ai loro occhi, cercando quindi di imitare tutte quelle alterazioni di forma e colore dovute all’influenza degli elementi atmosferici sull’organo della vista; nonostante questo elemento di novità rimangono però nel solco di una tradizione, direttamente o indirettamente sottomessa alla realtà. Va da sé che anche tanti acquerellisti hanno avuto lo stesso approccio o più semplicemente attratti dalla bellezza del soggetto reale, hanno provato a ritrarlo o, come vedremo in seguito, hanno utilizzato la tecnica dell’acquerello per “appuntare” visivamente alcuni dettagli dell’immagine da riprodurre. Ciò sicuramente è dovuto alla velocità esecutiva propria della tecnica dell’acquerello, alla semplicità degli elementi usati e non ultimo alla trasportabilità estrema. Quando, prima dell’invenzione dei tubetti di stagno era pressoché impossibile far uscire i colori dall’atelier, i mattoncini di pigmenti addensati con la gomma arabica rappresentavano un’ottima soluzione per realizzare bozzetti veloci, schizzi, accenni, direttamente dentro il paesaggio, sulle rive dei fiumi, in montagna e con tutte le condizioni atmosferiche.
Spesso l’acquerello è stato utilizzato per aiutare la memoria visiva a ricordare immagini complesse. Ma questo non è fare della pittura ad acquerello né significa creare opere d’arte. Ciò che si è appena descritto è come scattare belle fotografie di un paesaggio che si vuol dipingere o semplicemente che si vuol ricordare: quegli scatti non fanno del loro autore un fotografo. L’artista che utilizza le tecniche dell’acquerello solitamente non muove dal desiderio di descrivere qualcosa, quanto dal bisogno di ricordare, spesso ricordare poeticamente. Potremmo dire che l’acquerello è lo strumento di una ricerca elegiaca basata sul fondersi dell’artista con la natura, sentendosi parte di essa. Una ricerca che si avvicina molto ad una delle definizioni della parola “Arte” usata spesso da Van Gogh, che egli riprende da una «vecchia definizione baconiana della Tecnica […] L’Arte è l’uomo aggiunto alla natura»4. Dipingere con l’acqua significa dipingere con uno degli elementi primari del mondo naturale. Come il canto usa l’aria attraverso il respiro per produrre un suono risonante sia all’interno che all’esterno del corpo, mettendo in comunicazione diretta il dentro ed il fuori, così l’acquerello induce l’artista a confrontarsi con l’elemento di cui è fatto il suo corpo, l’elemento primordiale della gestazione, l’elemento che accoglie e genera la vita.
L’elemento che più d’ogni altro ha a che fare con il tempo, con il passato come con il futuro. Esiste una memoria dell’acqua: in memoria del liquido amniotico che avvolge il feto e filtra ogni odore, ogni sapore, ogni suono. Esiste un potere divinatorio dell’acqua: da sempre l’uomo ha cercato nelle sue trasparenze e nei suoi riflessi i segni del futuro. L’acqua è elemento di conoscenza di sé, è lo specchio primigenio in cui ritrovare l’autenticità del proprio essere ma è anche lo specchio in cui Narciso perde la coscienza di sé cedendo al più antico degli inganni legato all’immagine. Dipingere con l’acqua vuol dire tutto questo. Dipingere con l’acqua costringe a fare i conti con le profondità abissali fuori e soprattutto dentro sé stessi. Dipingere con l’acqua costringe l’artista ad improvvisare, a gestire la casualità, a fare i conti con la propria libertà e con la libertà dell’acqua, con la sua imprevedibilità. Chi dipinge con l’acqua sa che una parte importante del suo lavoro non può essere gestita. Chi dipinge con l’acqua sa che la sua opera cambierà aspetto nel tempo perché continua a vivere anche dopo l’ultima pennellata. Chi dipinge con l’acqua è cosciente che ciò che conta davvero è il fare, l’azione nel momento in cui si svolge; quindi l’opera è la testimonianza di una sacralità del fare, dell’unicità dei momenti in cui l’immagine si compie. È quello il frangente in cui il prima e il dopo perdono di importanza. Non conta più se l’immagine appena creata riproduce più o meno fedelmente una montagna o un albero, un acquitrino o un lago, un canneto o un cespuglio di rovi. L’immagine non rappresenta ma esiste nella sua unicità. In definitiva la vera pittura ad acquerello racconta l’invisibile al pari delle parole di Calvino quando narrano e descrivono una memoria visiva inattesa, improbabile e precaria. Così come essa si appoggia alle immagini per dare il senso del vero alla storia, così quest’ultime si aggrappano alle parole per divenire altro, per diventare sogno, poesia, luce e vento in faccia ai dirigibili svettanti nel cielo di Zirma.
2 – Taccuini
Sembra un problema tutto occidentale quello di voler archiviare la memoria delle emozioni ed il processo che le genera attraverso la conservazione di oggetti concreti o grazie alla reiterazione di prassi logico razionali. Vedremo come in alcune culture orientali l’immagine riprodotta non è associata automaticamente alla memoria di un luogo preciso, di un tempo stabilito, quindi la pittura non è, in sintesi, la rappresentazione visiva di un ricordo ma molto di più. Da sempre, e comunque da molto prima dello scarto in avanti impressionista dettato dalla pittura en plain air, ritrarre un paesaggio, le sue suggestioni estemporanee, una certa modulazione cromatica associata ad un certo luogo e in un certo momento del giorno o in una particolare condizione atmosferica è stata una prassi più che consolidata. Il taccuino diventa nel tempo un fedele compagno del viaggiatore ed uno scrigno di memorie, in prima istanza visuali ma sicuramente anche tattili e olfattive, sensoriali in genere. La tecnica dell’acquerello, molto prima dell’invenzione dei già citati tubetti in stagno (anche questa innovazione è legata al mondo impressionista ed all’avanzamento tecnologico e industriale della Parigi di fine ‘800), ha consentito di trasportare facilmente e con pochissimo ingombro gli strumenti di lavoro, compresa la carta, rilegata in volumi più o meno grandi, consentendo la stesura veloce del soggetto paesaggistico o di veduta. Queste ed altre caratteristiche hanno fatto della pittura ad acquerello la tecnica più utilizzata nella storia della rappresentazione di immagini, a partire dalle prime civiltà della storia sino ad arrivare ai giorni nostri. Sono state ritrovate infatti a Tebe, in Egitto, tavolozze e piccoli panetti di pigmenti colorati, mescolati a gomme naturali, risalenti alla diciottesima dinastia – 1400 a.c. – perfettamente conservati (fig. 2).

XVIII dinastia, regno di Amenhotep II (1425–1400 a.C.). Bosso con iscrizione intarsiata in blu egiziano; complessivo: 2,2x 21x 3,6 cm.
Cleveland Museum of Art (Ohio, USA), dono del John Huntington Art and Polytechnic Trust.
Se da un lato questa tecnica è effimera ed altamente soggetta a deperibilità, vista la sua sensibilità alla luce ed agli agenti atmosferici in genere, dall’altro garantisce, previo piccoli accorgimenti, una durevolezza che ha dell’inverosimile. Se è vero che la quasi totalità delle pitture murali egiziane realizzate su superfici esterne sono andate perdute, è altrettanto vero che molte delle decorazioni funerarie realizzate all’interno di tombe o in luoghi protetti sia dalla luce che dagli agenti atmosferici più invasivi hanno conservato quasi intatto il loro splendore. La tecnica dell’acquerello, più di ogni altra, ha resistito al passare dei secoli; la sua struttura iniziale e gli elementi non hanno cambiato, sostanzialmente, la loro natura. I pigmenti usati a Tebe nel XV secolo a.c. sono del tutto simili a quelli che si utilizzano oggi, così come rimangono essenzialmente simili gli addensanti, la gomma arabica su tutti. Quest’ultima è l’elemento principale e connotativo di questa tecnica. Come ricorda Gino Piva nel suo storico Manuale pratico di tecnica pittorica, «Questa gomma si ricava da varie specie di acacie d’Egitto e specialmente nell’Arabia, da cui il nome Arabica. […] Nella pittura ad acquerello rende i colori insolubili […]»5.
Questo elemento poi, a seconda delle epoche, delle latitudini, dei supporti usati e dei risultati ricercati è stato associato ad altre sostanze per così dire secondarie, quali ad esempio il fiele di bue, l’olio di noce, il latte di fico ed altri. Ancor più vicina alla tecnica odierna è senza dubbio la tradizione sterminata dei manuali di uso medico, farmacologico e botanico che, a partire dal medioevo, si sono diffusi in tutta Europa e in Asia. Erbari e florilegi, ricettari illustrati e naturalmente testi religiosi venivano redatti stabilmente e consultati già dai primi secoli dopo Cristo.
La diffusione amanuense di questi manoscritti, esclusiva degli scriptoria monastici lungo il medioevo, dalla fine del XIV secolo prese avvio anche in botteghe laiche, come quella dei rinomati fratelli Limbourg, nella cittadina belga di Nimega. In questi laboratori si alternavano quelle che erano le pratiche più diffuse di pittura miniata: la tempera all’uovo e il redivivo acquerello, che a differenza della prima non incorre nella formazione di muffe e salnitri. Infatti l’utilizzo dell’uovo al posto della gomma arabica necessita dell’aggiunta accorta di sostanze che possano distruggere ogni possibile formazione batterica, senza intaccare le caratteristiche fisiche e chimiche dei pigmenti. Tra i capolavori medievali da citare assolutamente vi sono due copie illustrate del celeberrimo De materia medica di Dioscoride Pedanio. Vissuto nel primo secolo dopo Cristo in Asia Minore, è l’autore di quello che è considerato il primo trattato di medicina, redatto in cinque volumi privi di illustrazioni. La copia più antica è conosciuta come Dioscoride di Vienna ed è un manoscritto, questa volta illustrato, risalente al VI secolo d.C. (fig. 3).

folio 83 recto del Dioscoride di Vienna (505 d.C.), 37×30 cm,
Biblioteca Nazionale Austriaca, Vienna.
Le straordinarie illustrazioni di piante officinali e mediche sono considerate tra gli esempi più alti di pittura all’acqua ed un’opera seminale, non soltanto in ambito pittorico ma anche dal punto di vista dell’impaginazione, dell’organizzazione spaziale e dell’equilibrio formale tra testo ed immagini. Il misterioso copista e miniaturista del VI secolo, non avendo a disposizione alcuna immagine di riferimento, si pensa abbia ricostruito forme e colori delle piante servendosi solo del testo dioscorideo. Se così fosse, egli avrebbe compiuto una meravigliosa operazione di ricostruzione visuale, scavando all’interno della parola scritta alla ricerca della linfa vitale propria di ogni atto creativo. In questo caso l’artista ha compiuto una sorta di miracolo, generando una memoria visiva dioscoridea postuma, senza cioè usufruire delle proprie visioni, ma immaginando ciò che Dioscoride ha visto mentre scriveva. Per certi versi è l’esatto contrario di quel che accade nella pittura di osservazione, dove una memoria a brevissimo termine serve all’operatore solo per il tempo che necessita per spostare gli occhi dal soggetto alla superficie della carta. Ed in tal senso il taccuino è una sorta di memorandum, un block-notes visivo che tantissimi artisti hanno utilizzato stabilmente, talvolta compulsivamente, ed usano ancora nella preparazione dei propri lavori.
Sicuramente il passaggio dal XVIII al secolo successivo ha segnato il consolidamento di una prassi creativa che vedeva il taccuino come parte fondamentale nella fase di gestazione dell’opera.
Basti pensare alle ricerche condotte dai vedutisti veneziani Canaletto e Guardi, solo per citarne due; a come hanno rivoluzionato il modo di intendere il disegno preparatorio; ma in merito alla tecnica dell’acquerello, una vera e propria âge d’or si concretizza con l’avvento del Grand Tour, il celeberrimo “viaggio in Italia” alla riscoperta delle meraviglie del passato. Un passato da documentare, da raccontare e catalogare. Una smania di scoprire rovine e trovare tracce sensibili di un mondo aureo, ma dai contorni non ancora del tutto definiti, colpisce schiere di intellettuali, studiosi e semplici appassionati, spingendoli in cammino lungo tutta la penisola italiana.
La pittura di viaggio diviene una disciplina che coinvolge non soltanto coloro che pittori lo erano già, ma anche coloro che nel condurre ricerche di vario tipo dovevano conoscere i rudimenti di questa arte. Ricercatori scientifici, naturalisti, ornitologi, evoluzionisti, geologi, filosofi, umanisti ma soprattutto storici e archeologi della prima ora comprendono che parte dei loro studi non possono che essere documentati per immagini.
Johann Wolfgang von Goethe rappresenta un caso emblematico di quanto saper dipingere ad acquerello fosse ritenuto, in quel contesto, una competenza pressoché indispensabile per la buona riuscita della ricerca, soprattutto in ambito scientifico. Questi partì segretamente da Karlsbad in Boemia il 3 settembre del 1786 verso l’Italia, attratto prima dalla biodiversità del paesaggio mediterraneo, poi dal patrimonio storico artistico. Goethe iniziò a condurre i suoi studi sulla botanica, sciogliendo «un nodo ancora insoluto di parola/immagine entro una vocazione creativa e anche scientifica in cui l’occhio (ma più ancora l’intera dimensione empirica dei sensi) avrebbe avuto sempre più una parte essenziale […]»6. Il grande pensatore tedesco comprese che per studiare la natura in assoluta completezza e coerenza scientifica non poteva che utilizzare i sensi al meglio delle loro possibilità. L’uomo, la macchina umana perfetta, è il più preciso strumento che esista, sia in termini analitici e di misurazione – giacché si muove attraverso un complesso apparato sensoriale – sia per ciò che concerne la rielaborazione dei dati, grazie alle capacità intellettive e mnemoniche del cervello. Tra i sensi a disposizione dello scienziato, la vista è quello che offre una maggiore quantità di dati per così dire “leggibili”, che restituiscono un’immediata possibilità di analisi empirica. In un approccio di tipo euristico, Goethe privilegia il senso della vista per individuare la regola generale, l’algoritmo cosmico che è dietro ogni caotica mutazione naturale. Egli intende individuare, se così possiamo dire, la radice di tale codice o anche solo la cellula, lo schema, il modulo, anche nei dettagli più semplici, nei comportamenti dei singoli elementi. Nella sua apparente semplicità, il singolo filo d’erba celerebbe nel suo ondeggiare alla brezza mattutina lo schema riassuntivo di tutte le leggi che guidano l’universo. La sua osservazione non poteva che avere la pittura come strumento mnemonico e di comprensione degli eventi. Convinto di ciò, proprio tra il 1786 e il 1788, Goethe si avvicinò al dipingere in modo sempre più profondo. Lavorò ai suoi acquerelli firmandosi con lo pseudonimo di Filippo Möller.
Stabilì un intenso rapporto epistolare e non solo con Jacob Philipp Hackert, noto paesaggista di stanza in Italia, al servizio di clienti eccellenti, come Papa Pio VI o Caterina la Grande di Russia, ma soprattutto noto per essere stato pittore di corte di Ferdinando IV di Borbone; ruolo grazie al quale ebbe la possibilità di studiare da vicino la collezione Farnese. Nel rapporto con Hackert, Goethe accrebbe le sue competenze tecniche e completò la riflessione sul valore delle immagini riprodotte: disegnare o dipingere dal vero il piccolo dettaglio come il campo lungo di una vallata conduce lo sguardo ad una osservazione analitica ma soprattutto contribuisce a comprendere le forme e a metterle in relazione con le loro caratteristiche fisiche, organiche e biologiche. Dipingere la natura significa comprenderne il senso profondo, stabilire con essa una sorta di relazione empatica oltre la fisica dei corpi. Grazie alla vicinanza con Hackert, Goethe concluse che la sua pratica pittorica era e sarebbe rimasta quella del dilettante appassionato. In nessun modo lo slancio entusiastico del semplice appassionato può colmare le lacune, soprattutto pratiche, di una disciplina basata essenzialmente sulle capacità manuali.
L’acquerello è strutturato sul gesto della mano e del corpo, sulla capacità di dosare le energie, gestire il peso del pennello in relazione alla sua forma ed alla quantità di acqua che contiene, alla qualità della carta ed alla sua capacità assorbente. La velocità del movimento e la sua traiettoria, sicura ma non rigida, determina la qualità del tratto e la riuscita generale dell’opera. Dopo il 1788, Goethe smetterà di utilizzare lo pseudonimo che aveva scelto per sé, perché finiranno le sue velleitarie ambizioni riguardo la pittura. Ciononostante continuerà a dipingere, utilizzando le pratiche pittoriche come strumento di analisi e conoscenza del soggetto. In definitiva, per il pensatore tedesco è come se fosse la pittura a validare l’idea e non il contrario. In tal senso l’approccio goethiano è molto attuale, poiché disgiunge la pittura di paesaggio o naturalistica dal famigerato messaggio, una zavorra inutile che nel corso dei secoli ha rallentato l’azione di grandi artisti ed ha inficiato la lettura di opere d’arte, soprattutto di quelle che non andavano assolutamente né comprese né interpretate, ma semplicemente godute.

Inchiostro di china e gesso rosso su carta. Stadel Museum, Francoforte.
Viaggiare significa cambiare luogo ed aria ad ogni respiro, vuol dire vivere nel cambiamento costante; perché mentre gli occhi acquisiscono nuove immagini ad ogni passo, la mente non può memorizzare ogni singolo fotogramma del cammino. La memoria del viaggio è la memoria del frammento, una memoria che decide quali passi conservare e quali, forse, dimenticare per sempre. Sarebbe sbagliato oltre che semplicistico definire il taccuino di viaggio come l’antenato del reportage fotografico. Oltre alle considerazioni già espresse sull’osservazione stimolata dal ritrarre, oltre al già citato rapporto di elitaria empatia autore-soggetto-modello, il taccuino è una superficie che può essere gestita dal punto di vista spaziale con incredibile libertà e la distribuzione dei pesi cromatici è facilitata dal formato medio, cioè quello che meglio si adatta ergonomicamente alle misure dell’operatore e che risulta più facilmente manovrabile, anche in condizioni precarie. Il taccuino è anche un quaderno e l’artista può facilmente passare dal disegno/pittura alla scrittura, in taluni e speciali casi, senza soluzione di continuità. Non solo notazioni sinsemiche, appunti o didascalie, ma vera e propria scrittura di paesaggio7, dove la parola scritta interviene sia formalmente sull’equilibrio visivo (su tutti gli elementi che compongono la grammatica del visuale: peso, ritmo, dinamismo, armonia, ecc.), sia come veicolo di trasmissione di valori semantici o solo di senso, che costruiscono quindi una poiesi “altra”, più completa e complessa.
Emblematico nella sua unicità di processo è il caso di quegli artisti cinesi – più spesso monaci zen – come Kao K’o-kung, che dal XII secolo in poi attuarono un modus operandi che si rivelò un modus vivendi, nel creare preziosi rotoli variegati con immagini della natura e versi struggenti. Prima di considerarsi poeti e artisti dovevano attraversare tre lunghe fasi di studio e applicazione: un primo periodo di apprendistato tecnico-pratico per l’acquisizione di alcune competenze operative, al fine di padroneggiare gli strumenti. Questa prima fase consisteva nel copiare la tecnica degli artisti più rinomati, imitando la stesura di dettagli naturali come ad esempio nuvole, profili di montagne, pini ed altro ancora. In un secondo momento e per un periodo abbastanza lungo, mediamente un quinquennio, intraprendevano viaggi e peregrinazioni, al solo scopo di contemplare la natura. In questa fase non dipingevano né schizzavano alcunché; l’unico fine era esercitare la memoria, immagazzinando quante più informazioni visive e meditazioni possibili sugli elementi naturali. Solo dopo questo secondo livello tornavano ai tavoli da lavoro, pescando da quel ricco bagaglio di immagini visioni poetiche straordinarie a cui aggiungevano, prima o dopo la stesura del paesaggio, dei versi che avevano il compito di completare il processo “d’incantamento”, tra meditazione estetica e poesia. Altresì era considerato puerile confrontare il dipinto con immagini reali o tentare di trovarvi somiglianze con questo o quel paesaggio esistente. Il rotolo di seta su cui venivano prodotte queste immagini era considerato alla stessa stregua di un libro di poesie, che per essere goduto appieno abbisogna di un ambiente e di una condizione di serenità che favorisca la meditazione, l’incanto, appunto8.

Collezione del governo nazionale cinese.
Il racconto del viaggiare coincide anche, in alcuni periodi specifici, con il racconto dal gusto esotico; si pensi alla moda, tra Settecento ed Ottocento, di viaggiare oltre i rassicuranti confini del vecchio continente alla ricerca di valori primordiali ormai considerati perduti nei grandi contesti civilizzati. Non si tratta più di cercare la calma compassata nelle rovine greco-romane, ma di rintracciare l’origine del mondo, la purezza primitiva e selvatica, rude quanto bizzarra. Il dibattito che ha visto scontrarsi, tra gli altri, Rousseau e Voltaire, ha generato due identità culturali in aperto scontro. Attorno al mito del buon selvaggio si è sviluppata una sorta di febbre dell’esotico, alimentata anche da alcune campagne militari con cui le grandi monarchie europee gestivano i malumori o mettevano a tacere le rivolte nelle proprie colonie. Una febbre alimentata dalla diffusione di immagini, disegni, raccolte di viaggio provenienti dall’africa subsahariana, dall’Egitto (si pensi alla campagna napoleonica), dall’Algeria e dal Marocco (spedizioni francesi del 1830-1832) o dall’Asia più remota, passando per la già battuta via della seta. Si parla anche di Orientalismo, un movimento culturale e artistico scaturito da questi presupposti. Iniziano ad essere stampati e diffusi i primi Carnet de voyage, raccolte visionarie che descrivevano luoghi lussureggianti, popolati da genti dalle vesti appariscenti e mai viste prima d’ora. Si pensi agli acquerelli di Eugène Delacroix, soprattutto a Un carnet du voyage au Maroc, opera magistrale attualmente conservata al Louvre, che riporta sulle sue pagine una gamma pressoché infinita di suggestioni, palpitazioni, legate ai luoghi e al paesaggio esotico del Marocco, ma anche ad un’umanità “pittoresca”, come la definisce lo stesso autore. Vi sono infatti una serie di figure dalle pose e dai vestiti tipici, su cui Delacroix sembra volersi soffermare come fossero gli studi per i personaggi di un nuovo, colossale progetto9. Un’esplosione di luce meridiana tipica delle latitudini di cui parliamo, che genera effetti di sovraesposizione fatti di ombre nette, tagliate; una luce lontanissima da quella tenue e soffusa di Parigi. Colori e forme variopinte, inconsuete, bizzarre si stagliano davanti agli occhi addestrati e sensibili di Delacroix che, scrivendo ad un amico, commenta questo turbinio di emozioni paragonandolo allo stupore della sua infanzia, quando ogni cosa è nuova e facilmente s’imprime nella memoria. Ed ecco che il taccuino racconta la meraviglia dell’artista, la sua estasiata frenesia nel ritrarre quel paradiso di luci nuove che sembrano vibrare ancora come nell’istante in cui balenavano nei suoi occhi. Molte di quelle immagini di mercanti e viaggiatori immersi nei paesaggi sabbiosi, terrosi e assolati, distesi tra il mare ed il deserto, sono di una leggerezza e di una sintesi modernissima, tanto da considerare opere come questa alla radice del lavoro dei fumettisti contemporanei. Il segno deciso ma fluido del lapis o di penne ad inchiostro crea contorni solo accennati, non chiusi. I colori non sono costretti nel confine della traccia e si mostrano tanto brillanti quanto trasparenti, lasciando intravedere la trama della carta appena dorata dal tempo. Tra le pagine del carnet si trovano ancora tracce di fiori e vegetazione che macchiando le pagine bianche tengono il segno del dipanarsi di un sogno al tempo stesso vero ed immaginato, reale e vivo, quanto fantastico. Ecco, il racconto del contingente diviene narrazione ideale grazie agli occhi ed alla mano di uno tra i più grandi artisti della storia.
Il Carnet realizzato da Delacroix durante la spedizione in Marocco del 1832, voluta da Luigi Filippo di Francia a scopi diplomatici, ha avuto un destino che possiamo definire fortunato.

Matita di piombo e acquerello. Museo del Louvre Parigi.
Conservato ed esposto al pubblico presso il museo del Louvre, oggi è costantemente monitorato ed ha mantenuto integrità formale e interezza; in altri casi meno fortunati i taccuini d’artista sono stati smembrati e le pagine divise e disperse tra collezionisti privati o antiquari ignari, peggio ancora finiti tra le mani di rigattieri senza scrupoli.
Di ogni taccuino d’artista andrebbe difesa e tutelata l’organicità e soprattutto l’unità e unicità: le singole pagine sono da considerarsi una parte indivisibile dal resto. Anche dove il susseguirsi dei fogli non ha alcuna consequenzialità manifesta, il carnet rimane una composizione che è solo un passaggio di tempo durante il quale si dipana un discorso visivo più simile allo scorrere gratuito dei pensieri che ad un racconto sequenzialmente ben strutturato.
3 – Del cielo e del mare
Accade di tutto attorno alla linea d’orizzonte, una linea immaginaria apparentemente sottile ma contenente infiniti frammenti di vita brulicante e nervosa. Visto alla distanza, l’orizzonte separa o unisce due piani geometrici su cui accogliere l’esistente: il piano orizzontale e il piano verticale si sfiorano generando stimoli continui che taluni artisti più di altri hanno saputo cogliere ed intrecciare mirabilmente. Alcuni di loro hanno raccontato l’orizzonte prospettico nascondendolo dietro nubi stratificate e dense o facendolo intravedere sotto nebbie trasparenti di un mattino d’autunno o utilizzando la pittura ad acquerello in modi talvolta inconsueti, apparentemente errati. In tal senso il caso di Turner è rappresentativo e ci racconta di un uomo schivo, non di rado rintanato negli stessi paesaggi turbinanti che dipingeva e spesso in uno strettissimo anonimato. Il suo sguardo, imparziale e acuto sapeva sottomettersi al gesto della mano, del corpo, ancora una volta, al fine di cogliere meglio l’impeto e la forza del manifestarsi degli elementi naturali. Nei suoi lavori l’orizzonte è spesso immaginato, intuito, è il letto su cui si gioca la partita degli elementi, la superficie su cui si sviluppa la loro spietata violenza: pioggia, nebbia, nubi, cieli e mari in tempesta sono i soggetti grazie ai quali Turner esprime quell’impeto sublime, proprio della retorica romantica. L’artista Britannico, partendo dal pensiero espresso da Goethe, citato addirittura nel titolo di una sua opera, arriva a concepire un intero sistema di elementi che intrecciandosi costituiscono il paesaggio. Elementi vivi, dinamici, colti nel loro incedere frenetico, ed in tal modo nascondono, velano gli oggetti avvolgendoli, condizionando la percezione che si ha di loro e della loro forma.
L’opera di Turner, si è detto spesso, anticipa l’Impressionismo e l’Astrattismo. Soprattutto, i valori che egli riesce ad imprimere alle sue visioni possono dirsi precursori di alcune istanze futuriste, per via della ricerca attorno al tema della rappresentazione del movimento, come pure le sue grandi tele sembrano anticipare l’Informale materico europeo della seconda metà del ‘900, per intenderci quello di Fautrier, Burri, Wols, arrivando ad ipotizzare anche una suggestiva comunanza con alcune trasparenze o profondità di Rothco. Entrambi infatti lavoravano per stratificazioni di colore, una materia mai del tutto coprente con proprietà riflettenti e trasparenti ma anche cangianti, vibranti; entrambi quindi trattano una materia viva, organica, assolutamente non astratta. Turner è uno sperimentatore alla ricerca continua di quel afflato vitale che sembra comparire sulla superficie delle sue opere, dentro piccoli crateri, tra le velature date ad acquerello sul colore ad olio o nei grumi di “paste alte”, colature di acqua sporca, acquaragia o essenza di trementina, impronte oleose e tanto altro. Turner infatti, oltre ad utilizzare gli acquerelli in modo classico li utilizza sovrapponendoli alla più grassa e spessa pittura ad olio in modo da creare velature e mezzitoni o per attenuarne la vividezza. In vero, operazioni di questo tipo erano largamente utilizzate lungo tutto il Rinascimento. Lo stesso Leonardo Da Vinci era un maestro nel sovrapporre campiture di colore usando tecniche diverse e apparentemente incompatibili; ma Turner lo fa in maniera nuova, azzardata, rendendo visibile o addirittura enfatizzando il contrasto che si produce da queste sovrapposizioni. Per questo fa un uso di strumenti consueti in modo inconsueto, soprattutto utilizzando strumenti nuovi, scelti per la tipologia di effetto desiderato. Impiega ad esempio stecche di legno, spatole di metallo di diverso formato, stracci, spugne o il palmo della mano per stendere il colore puro sulla tela, senza passare dalla tavolozza; utilizza colle per impermeabilizzare il colore e far si che si possa aggiungere altro colore, di altra natura, guazzo su olio o acquerello su olio e tante altre soluzioni. La pittura di William Turner travalica felicemente e senza alcun imbarazzo gli steccati che separano da sempre le diverse tecniche pittoriche giungendo, anche in questo caso a soluzioni che anticipano di un paio di secoli le pratiche più ardite della pittura informale materica. L’artista, prima di ogni altra caratteristica fa valere la sua libertà non solo dal punto di vista tematico e compositivo, ma soprattutto sul piano del procedimento e riguardo all’utilizzo degli strumenti non teme l’errore, anzi lo determina e da questo si fa ispirare per generare una nuova prassi tecnica da cui derivano nuove soluzioni formali, mai viste sino ad allora. La Gran Bretagna, patria putativa dell’acquerello tradizionale, fece fatica ad accettare le bizzarrie di Turner, il suo atelier era un vero e proprio laboratorio chimico al cui interno si conservavano materiali di ogni genere o pigmenti dalle provenienze più disparate, tutti scrupolosamente catalogati. Artisti come Turner spesso sono stati relegati a margine dei movimenti, anche a causa di una difficoltà evidente di classificazione del loro operato; anche dal punto di vista tecnico egli inaugura una stagione in cui le procedure classiche vengono ibridate rendendo ancor più difficile giustificare definizioni troppo strette del suo lavoro.

Guazzo e acquerello su carta. British Museum, Londra.
Come lui anche John Constable non ebbe vita facile nell’ordinata ed educatissima Londra del primo ventennio dell’Ottocento, a causa del suo amore verso paesaggi incontaminati e mai fortemente antropizzati. Quelle vedute così libere non furono evidentemente gradite alla Royal Academy che lo accettò come membro effettivo solo nel ‘29, trent’anni dopo la sua iscrizione al primo corso accademico.
Probabilmente sembrarono dissolute e troppo caotiche le sue vedute, in cui l’uomo tendeva a scomparire, avvolto da una natura stringente, totalizzante. Il lavoro di Constable era dinamico, veloce e fresco, anche nelle tele; l’abbozzo non era mai del tutto ricoperto dallo sviluppo successivo, ma sempre ben visibile. Nei suoi lavori, il disegno non delimitava e non appesantiva le forme ma rimaneva aperto, fluido, diventando una sorta di rampa di elevazione dei toni chiari. Troppo libere parvero le sue nuvole ritratte tra il 1830 ed il 1835 in una serie di studi ad acquerello e grafite. In particolare, l’esemplare conservato al Metropolitan Museum of Art di New York (fig. 8), nonostante le dimensioni ridotte (12,7 x 15,2 cm) possiede una potenza luminosa rara.

Metropolitan Museum of Art, New York.
Tutto giocato sui toni del grigio della grafite e del blu ceruleo, reale ed alcune velature ramate e giallastre appena accennate che conferiscono profondità al cielo solcato da nuvole sferzate dal vento e disposte orizzontalmente. Poi ancora le nuvole realizzate a pennellate veloci, da sinistra verso destra, sembrano correre ritmicamente verso il margine destro del foglio mentre l’orizzonte relegato in basso ha solo due piani; il primo, più vicino all’osservatore tendente al bruno e più pesante del secondo, una striscia blu cobalto più luminoso e dalla superficie irregolare, mentre il cielo accoglie le nuvole che si dispongono prospetticamente in modo costante, aumentando il volume di quelle in primo piano. Un paesaggio, questo, tanto etereo quanto vero, raccolto tutto in uno sguardo veloce su di un cielo in mutamento continuo, nel quale l’occhio arranca perché continuamente rallentato dalle tante variazioni tonali e spinto dalla linea d’orizzonte che tende a scomparire, ad affondare tra le nubi come fossero creste di onde spumeggianti di un mare in tempesta.
Simili ma più densi i cieli maculati di Gustave Courbet, il quale riesce ad imprimere il suo carattere deciso e ruvido alle trasparenze dei cieli di Normandia. Anche per lui il taglio prospettico è quasi sempre scorciato dal basso verso l’alto, quindi con la linea d’orizzonte bassa a schiacciare la superficie verso il fondo del foglio, come a voler sottolineare che la sua natura è terrena ma il suo sguardo è rivolto sempre e con meraviglia alla trascendenza del naturale. Le nuvole ed i prati verdi hanno una morbidezza cromatica ottenuta grazie a tanti strati di colori alternati su fondi pressoché uniformi. Il risultato vede la delicatezza dell’acquerello farsi densa, le campiture pastose non lasciano mai trasparire il colore della carta, ma è sempre un’altra tinta che si intravede in filigrana sotto la superficie. Il risultato, alla distanza, non è molto differente da una pittura a tempera grassa, a guazzo oppure addirittura ad olio. È evidente che l’autore si preoccupa di raggiungere quello che per lui è il risultato da ottenere; lo cerca, lo scava, lo costruisce strato dopo strato, livello dopo livello. Sia che si tratti di acquerello, sia che si tratti di altra tecnica, il modo di procedere sembra restare invariato. Egli interviene sulla materia fino ad ottenere effetti traslucidi e luminanze molto particolari e suggestive. Si vedano ad esempio i suoi cieli al tramonto, dove è facile trovare dei rossi, degli ocra o dei gialli molto saturi. Gli orizzonti di Courbet hanno perduto però lo slancio romantico dell’artista coinvolto emotivamente, ma è come se egli volesse offrire una visione nuova di quell’estasi, grazie ad un taglio che potremmo definire documentaristico.
A chiudere questa sintetica quanto effimera carrellata di poeti visivi che hanno giocato col cielo e col mare, rimangono da citare i grandi autori impressionisti, da Manet a Renoir, da Pizarro a Degas, passando per De Nittis, sino ad arrivare a Cézanne. L’acqua è l’elemento cruciale per il processo creativo di questi artisti, sia in quanto soggetto (gli impressionisti ritenevano che l’acqua fosse un ente pittorico ideale, perché capace di riflettere la luce muovendosi senza sosta in ogni direzione), sia come strumento di lavoro (l’acqua porta con sé le tinte e scorrendo più o meno velocemente sul foglio, in rivoli o a chiazze, costringe l’autore a lavorare repentinamente, lo obbliga ad improvvisare e ad adattarsi a quella libertà). Tra tutti Cézanne, a nostro avviso, ha utilizzato i colori ad acqua in modo più sistematico e originale. Sappiamo che egli ambiva a dare al colore dei valori plastici, cercava la volumetria degli oggetti attraverso le qualità dei colori più che con il disegno o il chiaroscuro. Sappiamo anche che vi riuscii in modo mirabile utilizzando i colori ad olio, stesi puri e mescolati sulla tela attraverso spatole metalliche che utilizzava poi per appiattire le chiazze di pasta colorata, sino a farne una sorta di mosaico grasso e denso dove ogni spatolata delineava una tessera cromaticamente diversa da quella adiacente. La campitura più o meno ampia si adattava perfettamente alla forma, si vedano ad esempio i celeberrimi “giocatori di carte” o il “ragazzo con panciotto rosso”, come le tante nature morte. Dobbiamo considerare però il processo che conduce Cézanne a raggiungere tali risultati. Egli infatti prima di lavorare ad olio si adoperava freneticamente alla stesura di bozzetti, schizzi e acquerelli sugli stessi temi. Come spesso accade, il materiale preparatorio cezanniano comunica altro e di più dell’opera finita, che invece nasconde alcuni valori per favorirne altri. Sappiamo che Paul Cézanne era un uomo tormentato, un artista perennemente insoddisfatto e quando, dopo le delusioni impressioniste (pur partecipando alle mostre del gruppo, sin da quella del 1874 nello studio di Nadar, non si è mai allineato al movimento restando sempre su posizioni autonome e spesso critiche rispetto ai suoi compagni), volle tornare nella sua Provenza a fare i conti con un passato familiare problematico, per via dei rapporti difficili con un padre autoritario che non lo aveva mai appoggiato. Qui i tratti problematici del suo carattere si acuirono a causa delle difficoltà economiche stringenti che non gli consentivano di occuparsi adeguatamente della moglie e del figlio, tenendolo invece legato alla figura del padre. In ultimo, diede il colpo di grazia al già compromesso umore dell’artista la pubblicazione del romanzo L’Opera di Emile Zola, l’amico di sempre, come lui partito dalla Provenza in direzione Parigi, carico degli stessi sogni e degli stessi entusiasmi giovanili. Cézanne non dovette rileggere due volte il romanzo di Zola per riconoscere sé stesso nei panni dell’artista sfortunato e ottusamente ostinato, protagonista de “L’Opera”. Si ritrovò nell’incapacità di leggere la realtà, in quella condizione di alienazione che non gli rendeva possibile vivere appieno e degnamente la sua condizione di padre, di artista e di uomo libero.
Non gli parve tollerabile che quell’amico fidato, l’unico rimasto dopo che era andato via da Parigi, lo avesse potuto tradire in modo così atroce. Questa condizione di sofferenza estrema lo portò a chiudersi ancora e di più, riversando in maniera compulsiva i suoi drammi umani nella pittura. Una pittura che divenne via via più spirituale ed eterea, pur mantenendo la solidità spaziale che è propria di Cézanne.
La figura umana andò svanendo progressivamente dalle sue opere, a favore del paesaggio, ed è qui, in questo contesto, che gli acquerelli ci restituiscono un Cézanne diverso, più luminoso, più riflessivo e delicato. Il tratto pesante dei lavori che stavano per ispirare Picasso lascia il posto a tinte slavate e atmosfere più intime, tenui e accoglienti, che raccontano l’altra faccia di un autore quanto mai controverso. Lo stesso profilo della montagna di Sainte Victoire (fig. 9) prende una connotazione più profondamente poetica quando viene ritratta ad acquerello; la stessa gestualità, gli stessi segni perdono il nervosismo della linea spezzata e la frammentarietà cromatica del colore dato a spatola per approdare ad un livello finalmente più visionario e lontano dalla affannosa, quanto inutile, ricerca di senso.
Parlando di Cézanne, il grande Kandinsky nel suo Lo spirituale nell’arte lo definisce come colui che «ha cercato una nuova legge della forma, […] più vicino alla pittura pura. Sapeva trasformare una tazza da tè in un essere animato, o meglio sapeva riconoscere l’essere in quella tazza. […] Porta la “natura morta” a un’altezza in cui le cose esteriormente morte diventano interiormente vive»10.

Acquerello e matita su carta 42,8×53,9 cm. Collezione privata.
4 – La poiesi dell’acqua
La pittura ad acquerello è sicuramente la tecnica pittorica che per sua natura favorisce un approccio poetico, è maggiormente simile alla poesia, quindi alla costruzione di un linguaggio che sappia andare più
in profondità nel racconto dell’animo umano. Se infatti la pittura ad olio pare più adatta al racconto realista, strutturato su ciò che è “vero”, l’acquerello appare più incline ad un lirismo sintetico in cui l’autore possa andare oltre il racconto stesso, esprimendo l’essenza di ciò che è “vivo”. «Ciò che importa non è quella soddisfazione che gli uomini chiamano verità, ma l’operation»11, così Horkheimer e Adorno, commentando il pensiero di Bacone nella loro Dialettica dell’illuminismo, affermano la necessità di un procedimento efficace che favorisca, nell’operosità del lavoro, la scoperta di particolari prima sconosciuti, di qualcosa che aiuti l’essere umano a vivere al meglio questa sua condizione di perenne instabilità. La distinzione, tra “Vero” e “Vivo”, per quanto approssimativa possa apparire, riteniamo sia un buon punto di partenza per raccontare quel «risveglio dell’anima al di là della fede» di cui parla Kandinskij nella sua riflessione attorno al lavoro di quella nuova generazione di artisti (la sua) che voleva costruire il proprio codice linguistico attraverso una sorta di poiesi visiva, con l’obiettivo di creare appunto opere vive, vibranti, capaci di parlare del mondo sensibile delle emozioni.
Non a caso l’acquerello tende a stabilire un legame intimo tra immagine e fruitore. Quest’ultimo viene catturato dalla vitalità dei colori e delle forme, anche quando queste non sono riconducibili al vero o addirittura quando possono dirsi astratte. Ancora una volta l’acqua colorata, con le sue trasparenze, le sue difformi profondità, con la sua tragica dolcezza, diviene elemento biologico riconoscibile anche visivamente. Un acquitrino insalubre ma brulicante di vita. Così questa tecnica stabilisce un rapporto elettivo con l’occhio dell’osservatore, lo fa gioire senza svelare gli arcani, senza rischiare la didascalia, senza mai rinunciare al respiro, al battito primordiale della creazione. In tal senso va intesa tutta la ricerca di Francesco Saverio Dòdaro sull’origine del linguaggio a partire dal grembo materno e sullo sviluppo dei valori espressivo-sensoriali dell’uomo a partire dalla gestazione, culminati poi nel movimento artistico Ghen o Movimento di Arte Genetica, di cui fu ideatore a partire dal 197612.
Ghen vedeva nell’elemento acqua la persistenza del concetto stesso di “vita”, l’acqua come contenitore e come contenuto, come elemento che conserva ospitando e rigenera veicolando ogni tipo di “essere”. L’artista quindi non fa altro che cercare di recuperare quella autenticità primordiale, quella esclusiva comunicazione che intercorre tra madre e figlio. Il suono della voce materna, il sapore del liquido amniotico e gli altri valori sensoriali che via via si sviluppano generano una memoria primordiale riguardante quella particolare condizione di armonia e perfezione tra due essere viventi che non sono ancora due individui distinti e separati.
Non a caso, tornando ancora su Kandinskij, la prima opera d’arte astratta è proprio sua ed è proprio un acquerello: Senza titolo del 1910 (fig. 10), nel quale finalmente la pittura si libera della verità delle cose che è solo esteriore, superficiale.

Acquerello, matita e inchiostro di china su carta, 49,6×64,8 cm. Centre Pompidou, Parigi.
Basta osservare una qualsivoglia immagine diagnostica degli apparati interni di un corpo o anche solo un tessuto al microscopio per comprendere che le immagini che riconosciamo come reali non sono che uno degli aspetti possibili del soggetto che si osserva da un determinato punto di vista e da un determinato soggetto osservante. I corpi hanno molteplici forme e diversi modi per apparire. L’acquerello del grande artista russo è come una pozzanghera che riflette un cielo, il suo, fatto di respiri, di suoni, di odori e di sensazioni colte nel loro migrare, dalla sua esperienza a quella del fruitore. Di fronte ad un acquerello che segue questo processo creativo lo spettatore osserva il farsi di un’immagine che non imita alcunché, ma si palesa come epifania dello spirito e come la nascita di un essere vivente ed in quanto tale impone all’astante un’interazione.
Ecco quindi generarsi una poesia che scaturisce dalla ricerca dell’istante aureo in cui lo spirito dell’artista crea estrinsecando la parte più preziosa di sé. Una gestazione visibile, un ventre gravido che conserva, protegge e nutre ciò che vi è di più importante. Ecco perché lo stesso Kandinskij definisce questa speciale figura di artista un “accordatore dell’anima”. Egli determina l’artista nuovo che però raccoglie eredità remote pre-illuministe, un operatore che al tempo stesso è essenza rivoluzionaria per un universo stantio come quello dell’arte e portatore di valori legati ad una spiritualità laica e indispensabile che sappia allenare l’anima alla difesa del suo spazio sacro. Un artista che non abbia timore di utilizzare tecniche antiche e che non veda nella sincronicità tra sé ed il mondo un valore assoluto da cui non potersi scostare.
5 – L’esperienza della luce
Nel dipingere con l’acqua si fa strada una sempre più evidente dimensione rituale, fattore questo che aiuta tutte quelle dinamiche proprie della creatività dello spirito di cui si è parlato. In questo senso non sembra esserci nulla di nuovo, ad esempio nella millenaria pratica pittorica orientale del Sumi-e ogni gesto ha un significato ed una connotazione spirituale ed altresì ogni azione è misurata nei modi e nei tempi ed è funzionale al dipanarsi di un rituale di natura meditativa. Anche la preparazione degli strumenti rientra nel contesto rituale. Respiri e gesti cadenzati, ragionati, ripetuti, favoriscono l’ingresso e l’uscita dal cuore del rito, l’atto di tracciare dei segni sul foglio. La pulizia dei pennelli e la loro disposizione, la preparazione degli inchiostri per la scrittura Shodō, l’arte della calligrafia Zen, sono azioni che fanno parte di una sequenza ben determinata in cui l’atto di scrivere/dipingere non è che uno dei momenti del rituale.
L’acquerello è fatto d’acqua in luce. L’elemento acqua risuona e vibra attraverso la luce che non è solo il fattore principale su cui si basa l’esistenza stessa dell’immagine ma ha anche la funzione di evidenziare, far brillare e dare corpo alle tinte, stabilirne le qualità e le potenzialità. La luce, da sempre, ha un valore iniziatico e rappresenta l’epifania del senso e l’avvenuto passaggio, la conoscenza nell’esistere. Nei misteri eleusini ad esempio13, si fa riferimento alla Epopteìa, cioè guardare sopra, elevarsi grazie all’esperienza della luce. Nel percorso iniziatico dei misteri dedicati a Demetra e Persefone l’intuizione della luce ha a che fare con la rinascita di Persefone rapita da Ade e condotta nel buio delle viscere della terra.
La purezza della luce balena come folgore attraverso l’anima e rende possibile la visione del sacro. Così la correlazione dei due elementi vitali, luce ed acqua, conduce l’artista al grado più alto della sua produzione e l’immagine che si sviluppa sulla superficie del foglio è una testimonianza, non una rappresentazione.
Ecco che artisti straordinari hanno saputo coniugare una sensibilità radiosa a competenze tecnico-procedurali raffinatissime, tanto che questi valori sono da considerarsi parte dello stesso processo creativo e mai disgiunti o in contrasto tra loro. Ad esempio molti degli artisti che hanno fatto parte del corpo docente della Bauhaus possedevano questo approccio duplice alle discipline: da un lato conservavano una sensibilità spiccata al senso dell’opera, ai suoi valori meditativi e spirituali, dall’altro un metodo razionale di analisi dei bisogni e sviluppo concreto del progetto, con un’attenzione particolare agli aspetti funzionali e pratici dell’opera prodotta.
Uno degli autori più rappresentativi di questa stagione così fervida è sicuramente Paul Klee14. Sperimentatore eclettico, egli sapeva alleggerire le forme fino a renderle astratte, il colore ora denso e corposo, ora trasparente e delicatissimo si stende attorno ad una linea di contorno che non sempre svolge questo compito, restando a volte solo una traccia sottile che pare voler diventare scrittura ma che ancora non può esserlo. Klee racconta il gioco, mentre gioca; il suo è un mondo fanciullesco e sognante, innamorato e coraggioso. Con Kandinskij tiene all’interno dei corsi che si svolgono nella scuola del Bauhaus alcune lezioni di Teoria della forma e dei laboratori di pittura, pittura su vetro e tessitura; il suo codice si sviluppa quindi su di un livello pratico molto elevato e strutturato su competenze tecniche specifiche ed un livello che tende alla trascendenza, nel quale trova lo scenario ideale la sua vena lirica, a volte nostalgica o melanconica, altre volte brillante e dinamica come alcune delle sue tinte calde ed accoglienti. Si veda ad esempio Stadt mit gotischen Münster (fig. 11), acquerello del 1925 conservato ai Musei Vaticani, in cui Klee riesce a trasformare un paesaggio urbano nordico, in cui si staglia il profilo di una cattedrale gotica, in una visione mediterranea, calda, quanto evanescente che sembra ritrarre una delle già citate città invisibili di Italo Calvino.

Musei Vaticani, Città del Vaticano.
Il suo lirismo onirico riporta l’osservatore ad una grazia fanciullesca ove regna l’incanto della fiaba, un ricordo appena accennato ma rassicurante. L’acquerello, ancora una volta, si presta a queste metamorfosi di senso, consentendo all’autore un cambio di paradigma ove scardinare stereotipi e costruire una sorta di mondo ideale, accogliente e dolce. Già un decennio prima di questa visione, in cui la poetica di Klee può dirsi ormai matura, egli ha affrontato e risolto in modo originale e personalissimo il tema del viaggio, della ricerca di un altrove ideale e vivo. Si veda Vor den Toren von Kairuan (1914), in cui una visione della città tunisina di Kairouan si trasforma in un racconto nell’animo dell’artista (fig. 12). Egli infatti affronta la scena come una sorta di miraggio fatto di superfici cromatiche semitrasparenti che si sovrappongono e si compenetrano. I profili delle case si confondono tra loro e con il cielo greve trattato allo stesso modo: le pennellate vagamente geometriche non identificano i volumi come in Cézanne, ma definiscono una specie di proiezione astratta, propria della geometria piana. Linee, angoli, piani, non compongono volumi, semmai li annullano, dimostrando come Klee rappresenti in quel momento storico un’alternativa credibile alla solidità cubista.

Kunstumuseum, Berna.
Allo stesso modo lavori di questa caratura ci fanno comprendere che lo slancio poetico di Klee va oltre l’esotismo e supera agilmente lo sterile stereotipo della ricerca del primitivo. Durante il suo soggiorno in Tunisia egli racconta di come si senta realmente rassicurato dal colore, perché sente di esserne posseduto, come annota nei suoi diari. La sua personale felicità risiede nella certezza di essere tutt’uno con il colore: ciò significa essere “pittore”.
Da Goethe a Kandinskij, sino a Klee, sembra intravedere un legame non solo teorico tra colore e acqua e tra questi e la luce. I primi due hanno addirittura indagato le proprietà dei colori tentando un approccio scientifico, ma tutti e tre hanno saputo cogliere il valore costruttivo e deterministico della luce. Non può esservi immagine senza di essa, né rappresentazione né espressione, né “verità” né “vita”. Al di là delle associazioni più o meno plausibili come le ricerche kandinskijane sullo spirituale nell’arte o le suggestioni che riconducono addirittura ai rituali misterici del mondo greco, certo è che la luce ha il potere indiscutibile di variare la percezione del mondo, di renderlo caldo e accogliente o freddo e inospitale. L’artista che si confronta con la tecnica dell’acquerello è chiamato, più di ogni altro, a cogliere questa qualità cangiante della luce. Dietro a tale affermazione vi è la natura stessa degli elementi della pittura ad acquerello: i colori, anche i più densi e pesanti, conservano comunque un grado di trasparenza, lasciano filtrare la luce sino a farla arrivare al bianco della carta. Il risultato è uno sfondamento prospettico ed una profondità spaziale che con alcune tinte, soprattutto con alcuni blu e con alcuni bruni può essere davvero infinita, abissale. I colori ad olio o le altre tempere hanno la sola qualità di riflettere la luce, solo in alcuni casi e grazie ad alcune tinte (lacche e simili), il colore acquisisce un grado di trasparenza importante e gradevole che però, sviluppandosi all’interno di un contesto di pittura “grassa”, nel complesso perde la sua freschezza. Come anche nelle tecniche a tempera quali il Guazzo o la tempera all’uovo, l’uso dell’acqua in abbondanza non fa che spegnere la brillantezza e rovinare la capacità riflettente del pigmento.
Solo l’acquerello consente alla luce di lavorare in piena armonia con i pigmenti, esaltandone le proprietà cromatiche; solo l’acquerello consente di illuminare i colori senza alterare, saturare o spegnere i toni.
6 – Confessioni di un malandrino
Quando nei primi anni Novanta del secolo scorso frequentavo il liceo artistico di Lecce, mi affascinava – e per la verità mi affascina ancora – la figura d’artista di Edoardo De Candia, personaggio difficile da inquadrare, allora come oggi. Un uomo che a quel tempo rappresentava quella che per me era l’ultima semenza di libertà espressiva, una sorta di baluardo, tra gli ultimi eroi in via di estinzione.
Artista cresciuto all’ombra del post-impressionismo, approda agli inizi degli anni Sessanta ad una specie di espressionismo meridiano, sino ad avvicinarsi a Ghen di Francesco Saverio Dòdaro, di cui si è già accennato. Un passato difficile lo aveva visto entrare ed uscire dai manicomi e dal tunnel dell’alcolismo. Una vita dissoluta non aveva ancora demolito il suo fisico imponente. Ciondolante ma comunque maestoso, con i lunghi capelli ingialliti dal sole, camminava sempre verso est, verso il mare. Anche in pieno inverno era facile vederlo in Via del Mare, la strada che dal cuore di Lecce corre verso San Cataldo, vestito solo di una camicia aperta sul petto, calzoni corti e sandali in plastica, stringendo in una mano dei rotoli bianchi di carta d’imballaggio e nell’altra un sacchetto della spesa con dentro un pennello, un paio di tubetti di tempera o inchiostri di fortuna e qualche bottiglia di vino o birra. A volte marinavo la scuola per seguirlo, per capire quale forza immonda lo spingesse, già ubriaco alle otto del mattino, verso quel mare dove si adagiava, a volte completamente nudo con i suoi pochi attrezzi, dipingendo disteso sulla sabbia, appena nascosto dietro canneti giovani a comporre le sue marine.
Diluiva i colori con acqua di mare e la patina biancastra di salsedine era spesso visibile. Altre volte la pioggia sorprendeva lui e quei poveri fogli lasciando i segni delle gocce d’acqua venute dal cielo a diluire il sale e i pigmenti ancora umidi. Acqua su acqua, per sopravvivere appena, come erba selvatica esposta al vento di tramontana sul dorso di una duna. Una linea orizzontale dal blu più intenso che poteva fare solo per avere un cielo in cui riposare gli occhi, ed un ocra gialla come giaciglio dove riposare le membra. La sintesi sublime e tragica della pittura di Edoardo De Candia è tra le più commoventi che io abbia mai visto: un rituale meditativo profondissimo che arriva con una sonora risata sguaiata e dissacrante. In questo dualismo e nella leggerezza effimera dei suoi acquerelli intaccati dalla salsedine c’è tutto lo smarrimento di un’intera generazione di artisti cresciuti nel secondo dopoguerra. Guardando da lontano e di nascosto quell’essere contraddittorio e puro ho approcciato la pittura prima sporcando il sangue e lo spirito, poi sporcando gli occhi e le mani.

Oggi, a distanza di decenni da quelle tensioni umorali, la pittura è diventata per me il luogo e il tempo che concedo al mio milieu, in una sorta di interocezione che mi offre la possibilità di conoscere il mio paesaggio interno. Uno scenario organico fatto di acqua, siero, fluidi, tessuti vivi, pulsanti e pensanti che rispondono alle azioni del mondo esterno attraverso azioni interne, che a loro volta producono immagini, pensieri, parole, luce. Ecco che la pittura diviene quindi un luogo interno in risonanza con l’esterno, con i paesaggi, gli ambienti ed i loro odori, con la polvere sugli oggetti, con il tavolo da lavoro, con la carta, con i recipienti e con i pennelli. Nel disordine, gli strumenti si mostrano pronti ad essere usati; nel disordine, gli strumenti si stratificano per importanza e frequenza di utilizzo e in ultimo per familiarità. Quindi il disordine diventa prassi, l’improvvisazione giornaliera diviene metodo.
La pittura è la carta, carta cotone o carta di riso, carta di imballaggio, carta mediocre, pesante o leggera, più o meno assorbente; la carta è la mia tortura, non ne possiedo mai abbastanza e allora ritaglio scampoli, lacerti, la riutilizzo nel retro. La mia carta è torturata da punte d’acciaio, solcata, incisa, stressata al centro e candida ai margini affinché il suo bianco si riconosca come superficie ospitante, come altare, come letto del fiume, come scrigno che riesce a conservare la luce. La carta a volte è il sudario sacro, altre volte è solo ciò che rimane di un tradimento.
La pittura sono i pennelli ammucchiati in un bicchiere. Raggruppati come monaci oranti contemplano l’unico tra loro che è stato scelto.
Setole umide, lavate due volte, la seconda volta lavate con la saliva per mantenerle morbide. Anche in questo caso un’affezione familiare mi tiene legato ad alcuni di loro più che ad altri, che pure devono presenziare, devono esserci. E poi gli stiletti e le lame, le punte e la grafite in mattoni taglienti per tracciare linee sicure e parole sovrapposte su piani.
La pittura è fatta di recipienti per le acque sporche: tazze, tazzine, brocche, piatti fondi che ospitano piccoli guadi, paludi sabbiose e dense o cristalline e terse. Alcune tazze in ceramica rigorosamente bianca hanno i bordi melmosi colorati di un bistro più che ventennale, verde putrido o grigetto ambrato. Queste acque conservano una memoria cromatica alla quale attingo stabilmente, una memoria data dalle pasture in eccesso adagiate sui fondali o sulle pareti che ancora sporcano l’acqua di tinte altrimenti impossibili da ottenere. Questi sono, di fatto, i miei colori; quelli che solo io posso usare e che si sono costruiti negli anni e solo in quei recipienti.
Dipingere ad acquerello significa avere il coraggio di ricordare con la mano ciò che gli occhi e la mente hanno dimenticato, vuol dire osservare il proprio passato galleggiare sullo specchio di una pozzanghera, che asciugando lascerà trasparire il futuro. La pittura è un dono inebriante e una mattanza di pensieri in cui è la mano a guidare gli occhi, mentre l’anima dell’autore assiste incredula al suo svuotamento.
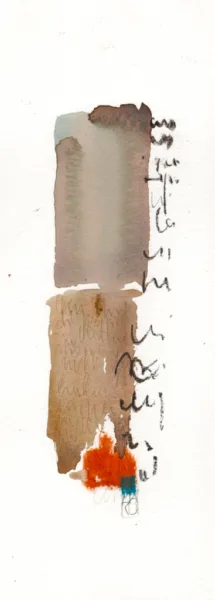
Acquerello e pastello ad olio su carta, 13,6×38 cm.
Collezione privata.

Acquerello e inchiostri su carta, 10×22 cm.
Collezione Privata.
- Artista. Docente di Storia dell’Arte. ↩︎
- I. CALVINO, Le città invisibili, Mondadori (= Oscar), Milano 2004, pp. 357-498. ↩︎
- H. BAHR, Espressionismo, Bompiani, Milano 1945. ↩︎
- M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano 1986, pp. 25-26. ↩︎
- G. PIVA, Manuale pratico di tecnica pittorica, Hoelpi, Milano 1949, pp. 213-214. ↩︎
- J.Ph. HACKERT – J.W. GOETHE, Lettere sulla pittura di paesaggio, a cura di P. CHIARINI, Artemide Edizioni, Roma 2002, p. 8. ↩︎
- Si veda E. MARULLO, Scrittura e paesaggio, Parte prima, in «Utsanga.it. Rivista di analisi liminale» (29 settembre 2019). ↩︎
- Cfr. in merito E.H. GOMBRICH, La Storia dell’Arte, Phaidon Press, Lonra 1950, pp. 150-153. ↩︎
- E. DELACROIX, The Journal, Phaidon Press, Londra 1941. ↩︎
- V. KANDINSKIJ, Lo spirituale nell’arte, a cura di E. PONTIGGIA, SE edizioni, Milano 2005, p.36. ↩︎
- M. HORKHEIMER – T.W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1966, p.13. ↩︎
- F. APRILE, Dòdaro: dal battito creatore alla rifondazione dell’anthropos, I Quaderni del Bardo Editore, Sannicola (LE) 2020. ↩︎
- Cfr. A. TONELLI (a cura di), Eleusis e orfismo. I Misteri e la tradizione iniziatica greca, Feltrinelli, Milano 2015. ↩︎
- Klee. I classici dell’arte – Il Novecento, Rizzoli-Skira, Milano 2004. ↩︎




